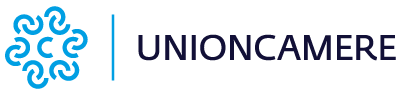EDITORIALE - L'accordo che non c'è
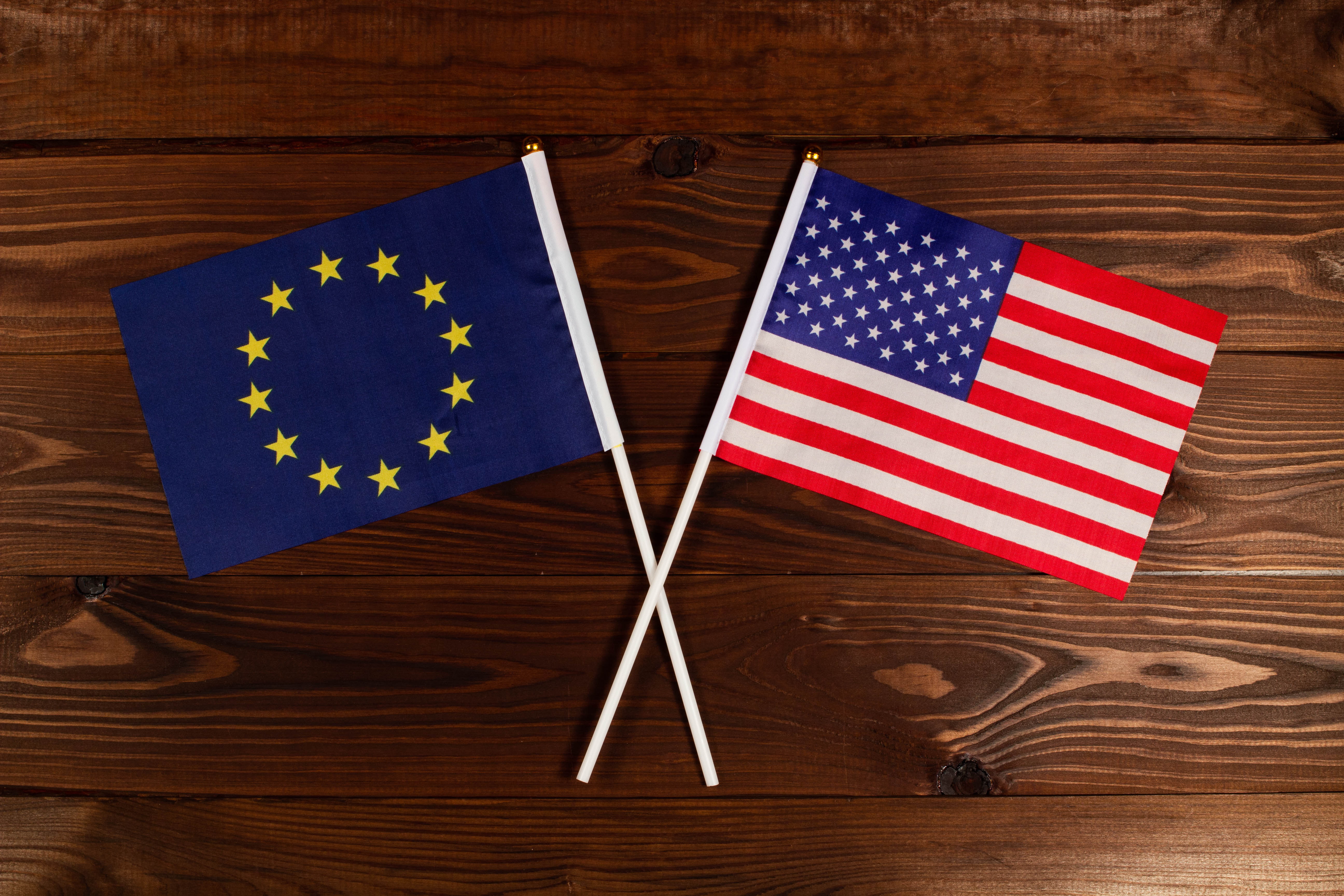
C’è un accordo. Ma non c’è.
Questo è il paradosso con cui Stati Uniti e Unione Europea hanno proclamato la fine della crisi commerciale più delicata degli ultimi anni. Washington esulta per l’«intesa storica» e per un riequilibrio finalmente favorevole agli interessi americani; Bruxelles, più cauta, evita toni trionfalistici e sottolinea la necessità di “definire meglio i dettagli”. Ma la reazione europea non è semplice cautela diplomatica: dietro le formule degli annunci c’è un’intesa ancora tutta da riempire di contenuti concreti.
Il dato di partenza è che il rischio peggiore, quello di una guerra commerciale in piena regola, appare (per ora) sventato. Gli Stati Uniti hanno rinunciato all’arma temuta dalle industrie europee: dazi fino al 30% su auto, semiconduttori, farmaceutica. Si opta per un dazio al 15% su gran parte dell’export UE destinato agli USA - una soglia più respirabile, che allenta la pressione su settori simbolo come quello automobilistico, pur lasciando la situazione ben lontana dal pre-2018.
Bruxelles, tuttavia, ha ragione a non cantare vittoria, perché si tratta di un dazio che è più del triplo di quello precedente (la tariffa media ponderata imposta dagli USA sui prodotti europei era infatti intorno al 4,8%). L’aumento pesa, specie in Italia, sul comparto industriale e agroalimentare.
È vero che alcune categorie strategiche - aerei, componenti elettronici, materie prime critiche - sono escluse dai nuovi dazi, ma la lista definitiva sarà oggetto di negoziati ancora da scrivere. Sul fronte più sensibile, quello dell’acciaio e dell’alluminio, le tariffe punitive al 50% restano in piedi: l’accordo prevede solo un “impegno a discuterne”, senza date e senza garanzie. Una promessa, insomma, o forse neanche quella.
E a complicare ulteriormente il quadro, emergono in queste ore divergenze sostanziali tra le due versioni ufficiali dell’accordo. Nella documentazione americana si dà per acquisito un ampio spettro di concessioni europee - in settori come la farmaceutica, l’acciaio, il digitale e l’agroalimentare – mentre la Commissione europea insiste nel presentare molti di questi punti come “ancora in discussione” o “da definire nei dettagli”. Non è solo una differenza di tono: è una divergenza di contenuto. Il rischio è che, mentre a Washington si celebra una vittoria politica già consolidata, a Bruxelles ci si ritrovi a negoziare da una posizione di crescente debolezza.
Inoltre, guardando anche solo le dichiarazioni da questa sponda dell’Atlantico, si capisce che la parte più pesante dell’intesa, però, ricade sull’Europa. Nei documenti trapelati si parla di maxi-acquisti di energia e semiconduttori statunitensi per 750 miliardi di dollari in tre anni, parte della strategia per ridurre la dipendenza da Mosca. E si cita una stima di investimenti europei in America pari a 600 miliardi, toccando anche il settore della difesa. Per ora non sono obblighi formalizzati, ma aspettative politiche che rischiano di diventare vincoli. E la bilancia, almeno sulla carta, pende più verso Washington che verso Bruxelles.
Per l’Italia il quadro non è roseo. Le forniture energetiche statunitensi non sono più così “a buon mercato” e rischiano di pesare sulle bollette industriali italiane, già più care della media europea. Inoltre, l’obbligo politico di concentrare gli investimenti in America potrebbe distogliere capitali che servirebbero alla transizione energetica e digitale interna.
A pesare ulteriormente sui prodotti europei venduti negli Stati Uniti contribuisce l’andamento del tasso di cambio euro-dollaro. Dall’insediamento di Trump, il 20 gennaio, a oggi, il dollaro ha perso il 13% del suo valore rispetto all’euro. Una svalutazione che, di fatto, erode i margini di competitività dei beni UE sul mercato americano. A spingere verso il basso la valuta statunitense non sono solo le incertezze globali, ma anche l’aumento di spesa pubblica dovuto a “Un grande e bello provvedimento legislativo” (in inglese “One Big Beautiful Bill Act”, entrato in vigore il 4 luglio 2025, dopo la firma del Presidente Trump, che prevede un forte incremento delle spese militari, delle spese per la sicurezza dei confini, e nuove misure di supporto per settori come l’industria dei semiconduttori).
Ci troviamo dunque a tirare un respiro di sollievo, ma solo parziale. La “crisi” è stata evitata, ma il compromesso ha il sapore della necessità, non della vittoria. E la prudenza con cui la Commissione europea comunica sull'intesa non è solo prudenza: riflette la consapevolezza che la vera trattativa comincia ora e che la maggior parte dei capitoli più controversi resta aperta.
Sarà quindi nei prossimi mesi che si capirà se la tregua si tradurrà in un nuovo equilibrio, o resterà solo una parentesi tra una stagione di tensioni e la successiva.
L’accordo dunque - più che esserci - sembra ancora tutto da scrivere.
Ana Sarateanu
Direttrice Unioncamere Europa
Aggiornato il