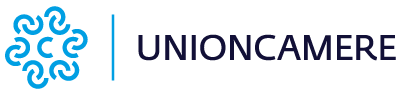EDITORIALE - Riforma della coesione: tra continuità e metamorfosi

La politica di coesione è da sempre il cuore pulsante della solidarietà europea. È quella parte del bilancio che, più di altre, incarna l’idea di un’Unione non ridotta a mercato ma comunità, capace di sostenere i territori rimasti indietro e di costruire convergenza laddove prevalgono disparità. Con il voto di settembre, il Parlamento europeo ha approvato una riforma che segna un passaggio delicato: aprire la coesione a nuove priorità – difesa, resilienza idrica, alloggi accessibili, infrastrutture energetiche strategiche – senza smarrire la sua missione originaria.
Le ragioni di questo cambiamento sono chiare. L’Europa di oggi non è quella del 2014, anno in cui fu approvato l’ultimo grande ciclo di regole per il periodo di programmazione 2014-2020; né quella del 2008, alle prese con la crisi finanziaria. È un’Europa attraversata da conflitti ai confini, dalla pressione migratoria, da eventi climatici sempre più estremi, da un’insicurezza energetica che ha reso evidente la dipendenza da fornitori esterni. Era inevitabile che un meccanismo di spesa pubblica tanto importante dovesse adattarsi. La riforma appena votata introduce maggiore flessibilità: gli Stati potranno riallocare parte dei fondi a favore di questi nuovi assi prioritari e ricevere, in cambio, prefinanziamenti più elevati e una quota più generosa di finanziamento UE rispetto al cofinanziamento nazionale. È un tentativo di accelerare l’impatto, riducendo il rischio che le regioni meno ricche restino intrappolate in burocrazie senza risorse di avvio. Eppure, dietro la logica della flessibilità si celano tensioni profonde.
La Corte dei conti europea ha ricordato in più occasioni che la politica di coesione soffre di una debolezza strutturale: la carenza di un orientamento efficace ai risultati. Troppo spesso si misura quanto si spende, non cosa si ottiene. Se a questo limite si aggiunge la moltiplicazione delle priorità, il rischio è che l’azione si disperda, che le risorse non producano effetti tangibili e che le nuove sfide diventino l’alibi per sottrarre linfa vitale alla missione di fondo: ridurre le disuguaglianze regionali. Anche gli economisti dello ZEW, istituto tedesco di ricerca economica, hanno sottolineato che concentrare gli investimenti nelle aree più fragili rimane la via più efficace per generare convergenza; ampliare gli obiettivi può sembrare moderno, ma rischia di indebolire la capacità trasformativa del fondo.
C’è poi un aspetto geopolitico che non può essere ignorato. La riforma riconosce esplicitamente il peso delle regioni orientali, confinanti con Russia, Bielorussia e Ucraina, prevedendo per loro un sostegno supplementare. È un gesto politico significativo: collocare la coesione dentro la cornice della sicurezza europea. Ma è anche un segnale di mutamento culturale. Quella che nacque come politica sociale ed economica diventa ora anche politica strategica, con risvolti legati alla difesa e alla preparazione civile.
Non tutti vedono questa evoluzione con favore. Alcune regioni temono che la coesione si snaturi, perdendo la sua identità originaria di politica redistributiva per trasformarsi in uno strumento di emergenza permanente. È difficile negare che ci fosse bisogno di un aggiornamento. Le crisi degli ultimi anni hanno dimostrato che i vecchi strumenti erano troppo rigidi e incapaci di reagire con rapidità. Ma l’equilibrio è fragile. L’efficacia della riforma dipenderà dalla capacità delle istituzioni di mantenere due promesse contemporaneamente: rendere la politica più agile, senza smarrire la sua anima solidale. E questa sfida non è solo tecnica, è politica nel senso più alto: riguarda l’idea stessa di Europa che vogliamo costruire. Il dibattito di Bruxelles, con i numeri della Corte dei conti, le analisi accademiche, le richieste delle regioni e le pressioni delle imprese, non è questione per addetti ai lavori. Ci tocca da vicino. Perché se i fondi di coesione diventano strumenti per finanziare la transizione energetica o la sicurezza militare, ogni territorio dovrà decidere come impiegarli, quali priorità anteporre, quali rischi accettare. E in questo passaggio si gioca la credibilità dell’Europa: un’Unione capace di reinventarsi senza abbandonare chi rimane indietro. Alla fine, la riforma non è solo un atto legislativo. È uno specchio: riflette le paure e le speranze di un continente che cerca nuove ancore di stabilità in un mondo in rapida trasformazione. Ci ricorda che l’Europa, se vuole restare rilevante, deve saper cambiare pelle, ma senza cambiare cuore.
Ana Sarateanu
Direttrice Unioncamere Europa
Aggiornato il