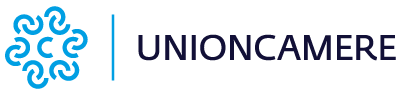L’auto elettrica europea tra annuncio e realtà: perché l’Italia non può restare a guardare

C’è un momento, a Bruxelles, in cui le parole sembrano poter cambiare la traiettoria dell’industria europea. Accade di nuovo con l’idea di una vettura elettrica “pulita, accessibile, europea”, evocata dal palco più solenne che l’Unione conosca. Un’immagine nitida, quasi cinematografica: catene del valore interne, tecnologie chiave in casa, cittadini che possono permettersi la transizione. Poi, lontano dai riflettori, resta la domanda che conta: come si passa dal fotogramma al film? La risposta, per ora, è in costruzione. Intorno alla Commissione si muovono consultazioni e prime riunioni con i costruttori (l’incontro con i principali dirigenti del settore automobilistico è previsto oggi, 12 settembre) , ma i contorni dell’operazione restano sfocati: strumenti, tempistiche, impegni finanziari, standard condivisi. Un’immagine potente che attende il lessico dei provvedimenti per farsi programma.
Per l’Italia la sospensione non è un dettaglio. L’automotive è soprattutto filiera: fornitori, progettisti, stampisti, elettronica, software, trattamenti superficiali, logistica. È saper fare che si accumula negli anni e che si può perdere in fretta se il percorso non è chiaro. Nelle valli della componentistica e nelle città dove si disegnano telai e plance, l’incertezza pesa quanto un calo di ordini. Ogni mese senza coordinate riduce l’incentivo a riconvertire gli impianti, aggiornare i macchinari, formare i tecnici per batterie e power electronics. È qui che la differenza tra annuncio e politica si misura in occupazione, export, gettito fiscale, tenuta sociale di interi territori.
La competizione non aspetta. Dalla Cina arrivano volumi e prezzi che mettono pressione sui margini; negli Stati Uniti gli incentivi legano produzione, ricerca e sbocchi di mercato. Se l’Europa vuole davvero un’auto europea, deve decidere cosa significa europea: batterie prodotte e riciclate in loco, contratti per materie prime critiche, una rete di ricarica che tolga l’ansia ai consumatori, energia a prezzi prevedibili, regole stabili che non cambino a metà partita. Non si tratta di proteggere le rendite, ma di stabilire un perimetro chiaro dove l’efficienza degli attori italiani possa contare: qualità, flessibilità, design, capacità di integrazione lungo la filiera.
C’è anche una dimensione culturale. La transizione non può essere ridotta a un bando o a una rottamazione: è un patto con i cittadini, che devono trovare colonnine funzionanti, auto davvero accessibili, un’assistenza diffusa. E con i lavoratori, che chiedono percorsi realistici di riqualificazione. L’Italia ha già vissuto cambi di paradigma industriale; ne ha memoria e anticorpi. Ma questa volta l’orizzonte è europeo per definizione, perché nessun singolo Paese può controllare da solo tecnologia, standard e mercati. Il rischio, per chi attende, è che qualcun altro scriva la sceneggiatura.
La politica industriale è fatta di dettagli: cronoprogrammi verificabili, obiettivi misurabili, strumenti finanziari coerenti con le dimensioni delle nostre imprese, criteri comuni che evitino la guerra dei sussidi tra gli Stati membri. Se il disegno europeo saprà offrirli, l’Italia ha le carte in regola per essere protagonista: distretti pronti a salire di scala, know-how di nicchia esportabile, centri di ricerca che possono diventare piattaforme. In caso contrario, resterà un’Europa d’intenti e un’Italia di attese, mentre la catena del valore si ricompone altrove.
Fonti: rielaborazione da notizie e dichiarazioni riportate da EUnews (11 settembre 2025) sull’iniziativa per un’“E-car” europea e le reazioni della Commissione.
Ana Sarateanu
Direttrice Unioncamere Europa
Aggiornato il