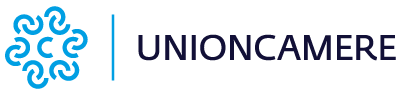QFP 2028–2034: nuova architettura, vecchi nodi

Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha presentato il primo pacchetto della proposta per il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028–2034, seguito da un secondo pacchetto il 3 settembre. Si apre così il cantiere del bilancio a lungo termine dell’UE, con un’impostazione profondamente rinnovata nella struttura e nelle modalità di allocazione delle risorse.
Come vi abbiamo già raccontato a luglio, la proposta ammonta a circa 2.000 miliardi di euro a prezzi correnti, pari all’1,26% del PIL europeo: quasi il doppio del settennato 2021–2027. Dal punto di vista dell’architettura, si dice addio ai sette “headings” tradizionali, sostituiti da quattro grandi pilastri più semplici e flessibili. L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione (da 52 programmi a 16 strumenti), armonizzare regole e tempistiche e aumentare la capacità di risposta a priorità trasversali.
Si conferma però che una quota stabile dello 0,1% del PIL UE (circa 25 miliardi l’anno) sarà riservata al servizio del debito di NextGenerationEU, i cui rimborsi – interessi e capitale su un fondo da 650 miliardi – prenderanno avvio nel 2028, in coincidenza con l’avvio del nuovo QFP. Al netto di tali oneri, l’effettiva dimensione del bilancio proposto scenderebbe all’1,15% del PIL UE: solo 0,02 punti in più rispetto all’attuale cornice. Ed è verosimile che, nei due anni di negoziato che ci separano dall’accordo finale, le cifre subiscano ulteriori limature.
Il secondo pacchetto ha meglio dettagliato i pilastri: i Piani nazionali e regionali di partenariato, che combinano coesione, PAC, pesca e politiche sociali, rappresentano la spina dorsale territoriale e sociale dell’UE, con 865 miliardi di dotazione; il Fondo europeo per la competitività (ECF), vero motore della strategia di innovazione industriale, dispone di 410 miliardi, di cui 175 per Horizon Europe, praticamente raddoppiato. Nel nuovo pilastro di azione esterna, Global Europe, sono destinati 200 miliardi, con 100 per il sostegno all’Ucraina. Gli strumenti trasversali e di crisi comprendono fino a 400 miliardi di riserve per emergenze e la gestione dei rimborsi NGEU.
Sul fronte delle entrate, il pacchetto di nuove risorse proprie è più sistematico: vi figurano la quota dei proventi ETS, il meccanismo di adeguamento carbonio alla frontiera (CBAM), il contributo legato alle accise sul tabacco (TEDOR), un prelievo sugli e-waste non raccolti e la nuova Corporate Resource for Europe (CORE), un contributo forfettario per le grandi imprese con fatturato superiore a 100 milioni. Completano la lista ETIAS e la tassa sulla plastica non riciclata. L’obiettivo è generare circa 58 miliardi all’anno, con un impatto contenuto sui contributi nazionali.
Da segnalare il nuovo Single Market and Customs Programme, ora integrato e dotato di 6,2 miliardi, oltre il doppio rispetto al periodo precedente, includendo lo sviluppo delle statistiche ufficiali europee. Rimangono da definire le ripartizioni all’interno dei Partnership Plans tra PAC e coesione, che saranno oggetto di negoziazione politica.
Il processo decisionale entra già nella fase calda: Consiglio e Parlamento aprono il confronto su cifre e ripartizioni con l’obiettivo di chiudere politicamente in Consiglio europeo all’unanimità e arrivare al voto finale dell’Eurocamera entro fine 2027; in parallelo, i regolamenti settoriali seguiranno la procedura ordinaria a maggioranza qualificata. Qui si misurerà la distanza tra ambizioni e vincoli: il Parlamento sottolinea che, al netto dell’inflazione e dei rimborsi, la spesa reale rischia di restare piatta mentre aumentano le priorità - competitività, coesione, agricoltura, difesa, adattamento climatico e transizione sociale - e respinge l’idea di una governance centralizzata in stile “Recovery” sui piani nazionali.
Per il dibattito italiano ed europeo, i nodi politici sono almeno quattro.
Primo: garantire che l’incremento nominale non venga interamente eroso dall’onere NGEU, assicurando una vera addizionalità.
Secondo: calibrare le nuove risorse proprie per evitare effetti di spiazzamento sugli investimenti.
Terzo: preservare la dimensione territoriale e la coesione, evitando centralismi nazionali che indebolirebbero l’attuazione, l’ownership locale e la capacità di adattare gli interventi ai contesti regionali.
Quarto: non lasciare indietro le PMI meno innovative. La spinta alla competitività non può esaurirsi nei progetti “deep-tech” o nelle filiere già forti: serve una politica di diffusione capillare dell’innovazione (voucher tecnici e manageriali, trasferimento tecnologico di prossimità, standard aperti, bandi snelli e ticket per l’adozione di soluzioni digitali e green) che riduca barriere d’accesso e costi amministrativi per le piccole imprese.
In breve, come scrivevamo a luglio, l’architettura proposta ha il merito di semplificare e concentrare. Con gli aggiornamenti di settembre, il quadro appare più leggibile nelle cifre e più esplicito negli strumenti fiscali a copertura del debito comune. La partita che si apre ora non è più se riformare il bilancio, ma come farlo senza sacrificare coesione e inclusione: competitività sì, ma con basi territoriali solide e con una traiettoria che porti anche le imprese più piccole e meno innovative - non solo le “campionesse” - dentro la transizione europea.
Ana Sarateanu
Direttrice Unioncamere Europa
Aggiornato il